
Anche per i Måneskin – tra i “corpi” e, insieme, gli “oggetti culturali” più cool del momento – il corpo è probabilmente “lo” strumento espressivo, non solo naturale, per eccellenza. Ne sono un’evidente dimostrazione le tante fotografie che mostrano i componenti di questa giovane rock band, poco più che esordiente e già all’apice del successo, nelle pose più svariate.
Ma, in realtà, cosa ci mostrano davvero quelle immagini?
Apparentemente tutto, ma, in realtà, forse nulla.
Tutto e niente, insieme.
Se così fosse, di fatto, saremmo di fronte ad una sorta di paradosso.
Un paradosso che dipende, in effetti, da cosa “leggiamo” dentro quelle fotografie mentre le guardiamo.
Ma, parafrasando il testo della hit che li ha portati a vincere nel 2021 sia il Festival di Sanremo sia l’Eurovision Song Contest, nel tentativo di comprendere appieno quelle immagini, non rischieremmo, forse, di andare anche noi… “fuori di testa”?
Speriamo di no, ovviamente, perché, come anticipato nel sottotitolo e come riaccenneremo ulteriormente in seguito – seguendo una sorta di percorso interpretativo – giungeremo alla conclusione che quello che, almeno “geograficamente”, è davvero… fuori in quelle fotografie, in verità, è “soltanto” il senso.
Il loro senso, il loro significato.

Uno sguardo tecnico rivolto, in particolare, ad una di quelle immagini scelta a caso cercando di descriverne le modalità di acquisizione di significato. Un capitale di valori, ideali, etc., di importanza e di visibilità talora persino… strategica, (anche) per i Måneskin.
Ma non solo, come accenneremo più avanti anche a proposito del fenomeno del “ritrarsi” della Fotografia e delle relazioni di questo strategico medium tra i media con la Morte.
Riprendendo precedenti riflessioni, in questo testo si proverà quindi a definire meglio da dove viene e come si alimenta di senso dall’esterno la dimensione significante interna all’immagine. Un transfert funzionale per decodificarle, “dargli” un senso, voce e parola – seppure tramite un “ventriloquo” – e, non ultimo, andando anche oltre, per “(ri)dargli”, all’occorrenza, persino la… vita!
Ed è proprio questo “meccanismo” che permette anche a questa fotografia – così come a qualsiasi immagine, del resto, pur essendo tutte, da un punto di vista tecnico, congenitamente anonime e “mute” – di superare il paradosso del quale si è accennato. E, superandolo, di “parlarci”. E non poco, “dicendoci”, piuttosto, tante, moltissime cose, ad esempio, su tutto il mondo che riguarda e circonda i Måneskin.
Sino ad arrivare, come già accennato e come ridiremo anche più avanti, persino a salvargli la “vita”!
Questa istantanea ci potrebbe quindi “dire” qualcosa, ad esempio, a proposito del percorso dei Måneskin all’interno della macchina produttiva dell’industria culturale non solo locale, che propone con successo al momento crescente questi musicisti ai diversi target internazionali di riferimento, in una miscela variegata di rimandi che oscillano, incessantemente, tra gli estremi del mito e della merce.
Una bella “merce”, sembrerebbe!
Almeno da quel che, sinora, sembra apparire. Per lo meno in superficie.

E, comprendendo idealmente, in questo ampio quanto immaginario campionario fotografico promozionale, anche l’immagine, del tutto informale e più volte rielaborata, che accompagna queste righe.
Bellezza, dunque.
Con l’attrattiva di un essere bello, che ha tutte le qualità di ciò che è ritenuto appunto tale in questo momento storico o che tale credono sia i sensi e lo spirito. Una dote non così tanto comune, che certo non pare manchi affatto a questo quartetto rock.
Una specie di sinergica armonia visibile, la loro, come la definirebbe forse U. Foscolo. Un’armonia che “buca” lo schermo, come si usa dire, e, penetrando oltre lo sguardo, si insedia nel cuore del pubblico.
Quella stessa Bellezza comunemente intesa, come ha ricordato A. Abruzzese, come uno degli “interessi abstracti dell’uomo”.
Una Bellezza che può anche essere figlia di una fotogènia propria o “indotta” nel (s)oggetto osservato e/o ritratto.
Fotogènia, che, nel caso dei Måneskin, gioca, evidentemente, a loro favore un ruolo non secondario.

Ne risulta, peraltro, una Bellezza a più dimensioni, tra le quali, non ultima, si può forse segnalare quella del corpo culturale che incarnano – anch’essa un’immagine, in fondo: una sorta di “fotografia” (anche sonora) – condensato in quell’emblematica quanto fortunata sintesi espressiva del “siamo fuori di testa” che, verosimilmente, ha rappresentato il trampolino di lancio per il vero salto di qualità della rock band verso il successo mondiale di questi giovani musicisti romani.
Un corpo, quello dei Måneskin, che, dati questi primi spunti, potrebbe interessare anche come corpo sociale. Un (s)oggetto di sicuro interesse, per la sua dimensione socializzata, innanzitutto per le c.d. Scienze sociali. In questa prospettiva, il corpo dei Måneskin, differentemente da quello di un animale che lo usa, seguendo l’istinto, sostanzialmente per i suoi bisogni più immediati (nutrirsi, riprodursi, etc.), ha delle finalità di norma più “alte”. I Måneskin, in effetti, usano il loro corpo e la loro musica per trascendere la “realtà” e costruire, così, per sé e per i propri fan, un mondo nuovo.
Un mondo nuovo, del tutto o almeno in parte diverso da quello attuale.
Il corpo, per questo gruppo rock nostrano, non è, dunque, semplicemente qualcosa che esiste al mondo, ma un’entità che già solo con la sua presenza, contribuisce a modificare il “reale” o, quanto meno, a reinterpretarlo e, quindi, ridefinirlo. Rimodulandolo anche sotto la spinta delle correnti sociali che, comunque, rappresentano. Un corpo poliedrico e, insieme, una specie di arcana porta “sensibile”, un varco “trasparente” e… attraversabile. Una sorta di pellicola fotografica, capace anche di registrare e di “riflettere” tutto quanto la attraversa.
Segni e tracce, di un corpo culturale: “il” corpo per antonomasia, secondo un certo orientamento, dei nostri tempi.
Un corpo comunque emblematico, quello dei Måneskin, che, tentando di trascendere il mondo concreto – una dimensione costantemente “inquinata” dall’evidenza incessante della temporaneità e corruttibilità del corpo umano – sembra proporre, tra i diversi e possibili percorsi e forme di resistenza, anche la ricerca della libertà e della diversità espressiva e, non ultima, della già accennata ricerca della Bellezza. Una qualità che, nei corpi tonici, anagraficamente e biologicamente ancora giovani dei Måneskin, certamente non scarseggia.
E le immagini che li ritraggono, ovviamente, non si limitano solo ad accennare superficialmente questa dimensione fisiologica e anagrafica del loro corpo, esplorandola, per quanto possibile, anche più a fondo, anche con qualche deriva già più… “spinta”. In particolare, attraverso una buona dose di fotografie di nudo (anche integrale) che caratterizza tanta parte dell’immaginario visuale anche di tanti altri artisti e/o musicisti. Una nudità che, seppure con le sue specificità, sembra essere in parte ispirata, per quanto concerne la sfera poetica, da ascendenze di orientamento naturista. Una poetica della Bellezza, che sembra celebrare sicuramente la gioventù e l’armonia fisiobiologica, ma, al tempo stesso, anche la dirompente forza d’urto creatrice delle nuove generazioni che il gruppo capitolino sembra ben impersonare. Una prospettiva, anche ideologica, che si contrappone, neanche tanto velatamente, a quella di generazioni coeve magari meno inclini al cambiamento.
Una nudità del corpo divenuta, peraltro, uno dei canali e dei motori della cultura visiva occidentale, sino alle sue derive – soft quanto hard – della pornografia.
Una cultura visiva che, attraverso la Fotografia, ha raggiunto il suo climax espressivo e, insieme, l’acme della sua efficacia, il momento culminante della sua funzione.

Il corpo nudo, anche quello (di solito) parzialmente svelato dei Måneskin, potrebbe rappresentare quindi anch’esso un sistema di segni di decodifica e di analisi di un mondo da rimettere, se necessario, tutto in discussione.
Un corpo nudo comunque corruttibile, emblema della fragilità umana. Una nudità dell’uomo che comunque non sembrerebbe, almeno in apparenza, la mera attestazione di uno stereotipo di presunta “normalità”. Uno stereotipo che la Fotografia, suo malgrado, ha comunque contribuito a diffondere nella cultura occidentale moderna, ponendo le basi per l’identificazione del “diverso”, del freak, della persona che si “discosta” da ciò che è considerato normale. Il corpo nudo è diventato, in questa (discutibile) prospettiva, uno strumento di comparazione, di confronto, di connotazione negativa, riguardo a possibili scostamenti dai relativi parametri di un’ipotetica idoneità e/o normalità. La nudità è quindi divenuta anche uno strumento ideologico “piegato”, nel corso del tempo, anche a specifiche norme e valori morali e politici, oltre che estetici. Un corpo nudo, dunque, ma, in ogni caso, non proprio “disarmato”. Una sorta di “arma impropria”, piuttosto. Uno strumento, quanto meno, di difesa, talora anche eversivo, per combattere contro i tabù preesistenti e, non ultimo, anche per affrontare scottanti questioni sociali e culturali del momento. Una forma di riappropriazione del proprio corpo, sviluppatasi progressivamente, a partire dal periodo delle Avanguardie, e via via trasformatosi in uno strumento di contrasto alle diverse forme di censura dell’espressione ancora tuttora dilaganti.

Il corpo nudo, attraverso la Fotografia è quindi via via sempre più divenuto un “varco” strategico di accesso e transito da e verso il mondo.
Un mondo che, attraverso questa “porta”, attraverso lo sguardo, esplora e valuta. E, così facendo, “dialoga” con il mondo e gli “descrive” il suo punto di vista. Un dare e avere che, in cambio, delinea nuovi e magari sconosciuti spazi di coscienza e conoscenza.
Il corpo non è dunque mai separato dal mondo.
All’opposto, è proprio “lo” strumento che ci permette di collegarci al mondo e, di volta in volta, misurarlo, organizzarlo e, eventualmente, anche di “incamerarlo”. Il corpo ci permette costantemente, quindi, di avere un’idea del mondo. Un quadro certamente con delle lacune, limitato e parziale, quanto astratto e inevitabilmente impreciso del “reale”. Ed è proprio con questo “mezzo” aleatorio ed incerto l’essere umano fa esperienza del mare di materia, di saperi, di culture e, quindi, di senso nel quale “nuota” incessantemente.
Tra questi, potrebbero eventualmente ricordarci i Måneskin, ci sono, per quanto ovvio, anche la musica e l’espressione corporea.

Musica e movimento intesi, sinergicamente, come un universo simbolico e gestuale di esplorazione degli spazi, non solo fisici, che “avvolgono” i corpi nella contingenza di ogni performance. Una rappresentazione simbolica del cammino di ricerca verso la conoscenza e la verità che caratterizza il cammino dell’essere umano. I gesti del musicista e/o del cantante che lo accompagnano durante l’esecuzione di un brano, seguono sovente uno specifico intento espressivo, una sorta di ideale cammino narrativo, percorso anche attraverso una continua rimodulazione prossemica degli spazi – metaforici e non – che “imprigionano” il corpo concreto di volta in volta coinvolto nelle sue “prestazioni”. Un corpo che è sia il punto di partenza sia l’orizzonte e la destinazione finale anche del cammino disvelatore del percorso narrativo rivelato dall’azione gestuale. Un corpo biologico che cantando e muovendosi tratteggia quindi un perimetro semantico, una cornice di interesse, un dentro e un fuori che imprimono a ciascuna esecuzione un marchio di esclusività. Un’impronta ogni volta unica all’atto, al gesto attraverso il quale, passo dopo passo, la parola suono, ovvero la musica, e la parola movimento, ossia il moto del corpo, si esprimono, confondendosi e divenendo essi stessi un ulteriore corpo significante. Una gestualità che non è, di norma, mai “inconsapevole”, ma sempre finalizzata, indirizzata. Un atto “politico”, anche in quest’ambito, determinato a percorrere un sentiero più o meno definito, volto a disvelare una determinata dimensione e/o una specifica “verità”. Gesti “orientati”, dunque, attraverso gli spazi fisici e sonori via via esplorati. Gesti e parole che, tuttavia, se presi singolarmente e scollegati da uno specifico e più ampio progetto di fondo e, pertanto, privi di una possibile destinazione finale, rischierebbero di apparire come atti chiusi in sé stessi, insensati, finanche “gratuiti”, che non rinviano a null’altro. Una condizione indispensabile perché anche lo spazio della musica cosi come quello del corpo in moto sono a loro volta ridefiniti dai gesti stessi, appunto, della musica e del movimento. Attraverso quei gesti l’atto “politico” condensato nell’interpretazione viene “piegato”, per così dire, oltre che ad una specifica destinazione d’uso anche a una ben definita cornice interpretativa. Un perimetro interpretativo e un (ri)orientamento verso una (talvolta) nuova e, eventualmente, anche differente verità. Per lo meno quella circoscritta dai gesti, ovvero dalle “parole” con le quali queste espressioni culturali si esprimono e, nel contempo, formulano ininterrottamente anche (meta)discorsi su sé stesse. Con i suoi tanti linguaggi espressivi il corpo materiale, pure attraverso la parola, le note e il movimento, ogni volta diviene una specie di metaforico varco, una specie di apertura verso/sul mondo. Senza questa sorta di cerimoniale espressivo il corpo fisico, muto e inerte, potrebbe avere – in termini tecnici – spazi diversi per esprimersi e “parlarci” del mondo, limitandosi, eventualmente, “solo” ad immaginarlo, senza forse condividerlo proprio appieno. Senza questa propensione comunicativa, senza questa cangiante liturgia di atti, le parole, le note, i gesti, potrebbero quindi risultarci addirittura senza alcun senso e incapaci, quindi, di “tradurci” il mondo. Dissolvendo, così, anche le molteplici capacità espressive e gli sforzi narrativi del corpo reale “a contatto” con il mondo.

Le diverse geografie visive create dai corpi fotografati dei Måneskin condenserebbero, in questa prospettiva, una sorta di esempio rappresentativo, tra altri possibili. Un esempio di “traduzione” in immagini delle ininterrotte interrelazioni del nostro corpo duplice – dell’anima e del corpo, per intenderci – con il mondo. “Traduzioni”, dunque, realizzate collegando ad ogni atto, ad ogni idea creata, il relativo contenuto. Ed ogni volta questo corpo doppio si rimette quindi “in gioco” sostenendo il suo rapporto con il mondo. Queste connessioni, questa interdipendenza, sembrano documentare concretamente le tante espressioni dell’anima e della coscienza del corpo e del suo essere nel/al mondo. In questa prospettiva, il corpo può apparire esso stesso sia una “cosa”, un oggetto sia, al tempo stesso, “lo” strumento (accennato in apertura) atto a tessere questa trama di scambi materiali e/o simbolici, nel fitto e continuo intreccio dialettico con il mondo.
Una rete di senso, intessuta incessantemente per dare e darsi un senso, per dare e darsi un fine.
Per dare un fine anche a quelle esistenze scandite magari dalla sofferenza e dal dolore. Dolore e sofferenza che mettono in evidenza tutta la fragilità umana.
Una fragilità umana alla quale, sembra che i Måneskin tentino di opporre, tra gli antidoti possibili, anche la Bellezza.
Una Bellezza che, considerata anche la loro giovane età, emerge e li “attraversa” vivace e fresca come l’acqua di un ruscello di montagna. Una narrazione (anche estetica) che sembra dipanarsi progressivamente come la pellicola di un intrigante lungometraggio.
Ed è proprio nell’ambito cinematografico, al quale i Måneskin con This Is Maneskin sono peraltro già approdati nel 2018, che il termine fotogènico è stato utilizzato inizialmente e ha cominciato a circolare in maniera abituale, per quanto sia stato originariamente preso in prestito proprio dal mondo della Fotografia, divenendo poi universalmente sinonimo di un soggetto idoneo, per le qualità estetiche, a poter essere ripreso perché, appunto, fotogènico.
L’aggettivo fotogènico, andando all’etimologia del termine, proviene dall’inglese photogenic (composto da photo– «foto-» e –genic «-genico») e dal francese photogénique. Entrambi i termini, originariamente avevano il significato dell’aggettivo italiano fotògeno, ovvero quello di «atto a impressionare un materiale fotosensibile». Il termine fotogènico ha dunque variato il suo significato nel corso del tempo, passando dal riferirsi a una caratteristica specificatamente tecnica alla temuta connotazione estetica dei nostri giorni. Una qualità, che, l’universale e pervasivo mondo dei social, ha reso oggigiorno ancora più “indispensabile” e strategica. Un problema per tanti affatto astratto e per molti di questi, nemmeno arbitrario. Una preoccupazione in crescita esponenziale, a quanto pare, che, rispetto alla dimensione più contenuta e/o più di nicchia del passato, risulta ulteriormente amplificata nell’economia relazionale della rete. Una dimensione nella quale, ad esempio, il possesso o meno di una simile qualità, può avere riflessi significativi sulla propria visibilità e/o (eventuale) autopromozione, come ben sapranno i Måneskin. Effetti, conseguenze, che, concretamente, possono tradursi in successo o insuccesso del protagonista delle relative immagini, a prescindere dalla destinazione d’uso alla quale sono, di caso in caso, eventualmente indirizzate: loisir, portfolio, follower, etc.
La fotogènia condensa, quindi, un potenziale talora persino strategico, grazie alla sua capacità di amplificazione delle qualità estetiche del protagonista ritratto. Una specie di “arma” non convenzionale, atta concretamente anche ad “offendere” possibili antagonisti. Un’“arma”, dunque, perché la fotogènia può essere colta “al naturale”, dando un adeguato risalto alla bellezza già presente in ciò (persona o cosa) che viene raffigurata o, all’occorrenza, amplificata o persino “creata”, ove manchi, mediante l’utilizzo di uno dei tanti software dedicati.
La fotogènia, in ogni caso, è di norma considerata un attributo non tanto soggettivo, quanto oggettivo. Una qualità, dunque, un “talento” estetico naturale che, semplicemente, talune cose, così come talune persone, hanno, altre no. Questa qualità, ancor più se è naturale, può essere rilevata, in particolare, nella semplicità, nella naturalezza e spontaneità di una persona. Qualità che certamente non sembra mancare al gruppo romano dei Måneskin. Qualità, queste, che, in fase di produzione o di post-produzione, devono comunque essere adeguatamente rese e valorizzate. In questa prospettiva, tutto, oggettivamente, può risultare fotogènico. Anche la “realtà” può dunque rivelare un suo “lato” fotogènico. Ne è una dimostrazione ormai incessante – e evidentemente contrapposta alla precedente visione “naturale” della fotogènia – la dimensione iperbolica e “sovrannaturale”, sempre più artificiosa e artificiale (sino e oltre la fiction, se del caso) dei media contemporanei. Le loro rappresentazioni non hanno ormai – nel bene e nel male – praticamente quasi più nulla di naturale. Speriamo che non divenga questo, almeno in via assoluta e prevalente, anche il destino di questa giovane band capitolina.

La fotogènia rappresenterebbe, in ogni caso, e, quindi, anche per i Måneskin, la qualità – naturale o artificiale che ne sia stata l’origine – in grado di donargli persino una sorta di immortalità, preservandoli virtualmente dalla dissoluzione e “resuscitandoli” potenzialmente all’infinito in tutte le immagini nelle quali sono stati o saranno raffigurati.
La fotogènia potrebbe quindi salvare anche i Måneskin da un’eventuale quanto possibile “morte” o, per lo meno, ritardarne l’arrivo.
Una sorta di morte immaginaria, s’intende, come quella che potrebbe essere causata, ad esempio, ad un eventuale calo d’interesse futuro nei loro confronti. Una specie di protezione “soprannaturale”, che, come appena accennato, si realizzerebbe attraverso il transfer attivato dalle tante immagini nelle quali vengono raffigurati questi musicisti. Un transfert che, per quanto ovvio, prenderebbe forma solo nel caso “resista” in loro un tipo di Bellezza, come già detto, fotogènica. E solo in presenza di una simile e persistente forma di amplificazione estetica, che agisca come un’efficace e duratura profilassi, potrebbe forse essere meglio salvaguardata, per quel che qui ci interessa, anche la vita artistica della formazione romana, “sconfiggendone”, per lo meno a livello visivo, la comunque possibile (loro) “morte”. E, in tal modo, “facendo sistema” con le loro altre qualità umane, con il loro talento, con la loro forza d’urto di gruppo emergente, etc., garantirgli, magari per sempre, un successo crescente e, non ultima, una carriera professionale lunga ed inossidabile.
E, parlando della fotogènia, si è inevitabilmente evocato anche il rapporto che, da sempre, la Fotografia intrattiene anche con la Morte.
Una dimensione che, per quanto risulti totalizzante, tenendo conto della loro già accennata giovane età, potrebbe non essere proprio prioritaria nell’agenda e, ancor meno, nelle “corde” di questa (comunque) sensibile rock band.
Al riguardo, R. Barthes – il semiologo francese, autore, fra l’altro, del celebre La camera chiara – ha evidenziato la forza anche trascendente e la tenacia di questa relazione, facendo riferimento, in modo particolare, alle immagini di ritratto. Più nello specifico, a livello fenomenologico, ci ha ricordato come in qualsiasi ritratto, in special modo se la persona e/o il corpo raffigurato sia quello di una persona ormai scomparsa, nell’immagine possa emergere e configurarsi una sorta di gesto “magico”, onnipotente. Un gesto speciale, anche per le ragioni già accennate, e, a tratti finanche trascendente. Una “magia”, quella della Fotografia generalmente tesa, non tanto a celebrare la dissoluzione del mondo, quanto, sebbene per frammenti visivi, a “ridargli la vita”. Un dispositivo simbolico, la Fotografia, di resurrezione visiva e, insieme, di conservazione della memoria. Memoria, come di norma ha ben presente che opera nel campo dell’entertainment, che potrebbe altrimenti e irrimediabilmente, magari all’improvviso, come d’incanto, anche dissolversi. Una memora che fa della Fotografia una strategica protesi affettiva e documentaria. Anche per queste ragioni, nell’immaginario collettivo, la Fotografia, nonostante il suo “ritrarsi”, si conferma tuttora come uno dei più importanti – se non, addirittura, “il” medium privilegiato – per la conservazione del passato. E non solo quello personale.
Una Fotografia che, “congelando” il Tempo, e, quindi, per quel che potrebbe interessare i Måneskin, dovrebbe poter provocare anche una sorta di disorientamento nell’osservatore, raggiungendo il culmine dell’efficacia del medium.
Un confine estremo, secondo G. Celant, che si realizza allorché:
“La fotografia raggiunge la sua massima soluzione solo quando è in grado di ostacolare il flusso inalterato dell’esistente e a trasformarlo in visione pietrificata.”

Una funzione strategica, quella della “pietrificazione”, che la Fotografia svolge da sempre, in ogni caso, in modo discreto, in sostanza senza mai mostrarsi. Si, perché la Fotografia si sottrae sistematicamente, ha aggiunto il semiologo francese per “lasciare spazio” al (s)oggetto, al corpo, all’oggetto, all’ambiente ritratto nell’immagine. E, così facendo, la Fotografia non solo “rende presente” il “corpo” della scena raffigurata, ma la rende anche “al presente”. Al riguardo, R. Barthes ha inoltre paradigmaticamente ricordato che la Fotografia è:
“sempre invisibile.”
Ciò detto, ogni immagine fotografica, come potrebbe esserlo nell’ambito di questa riflessione, una qualsiasi fotografia dei Måneskin, sembra inoltre non perdere mai del tutto la sua forza documentativa. Una proprietà che non riguarda tanto e/o esclusivamente il (s)oggetto raffigurato nella fotografia quanto la relativa componente temporale. Aspetto, questo, che lo studioso transalpino ha evidenziato ulteriormente, aggiungendo che:
“Da un punto di vista fenomenologico, nella Fotografia il potere di autentificazione supera il potere di raffigurazione.”
Uno degli esempi rappresentativi, tra i diversi possibili, sempre pensando alla rock band italiana, potrebbero certamente essere, come quella qui proposta, le loro fotografie di gruppo.
Si tratta di una parte costitutiva rilevante, planetaria e trasversale del “corpo” poliedrico della Fotografia. Un genere al quale la Fotografia da sempre attinge e si alimenta. Un corpo sociale di rilievo e, insieme, corpo esso stesso nel più ampio corpo della Fotografia. Parte di un organismo articolato, dunque, “testo” significante e, insieme, documento prezioso e trasversale non solo per la Storia della Fotografia ma, più in generale, dell’Arte e della Storia della società non solo contemporanea. Senza dimenticare, poi, le “incursioni” di questi come di altri generi anche in altri ambiti, apparentemente anche molto distanti e dei quali si riaccennerà più avanti, quali quello dell’Arte concettuale, dei ready made e, non ultimo, delle installazioni. Un tratto distintivo di questo genere di immagini, come potrebbero testimoniare anche quelle che ritraggono i Måneskin, è verosimilmente individuabile nelle pose spesso stereotipate dei soggetti che vi sono ritratti. Corpi rituali che applicano precise regole di ingaggio in occasione, ad esempio, di celebrazioni, eventi, etc. Liturgie specifiche, con tanto di mimica, prossemica e pose di rito. Una sorta di elementi di certificazione “doc”, di garanzia di prodotto di origine controllata e delle eventuali relative retroagenti agenzie di socializzazione. Agenti sempreverdi, tradizionali e/o neoformazioni sociali che siano, che agiscono anche da collante sociale. Marchi di autenticità, dunque, e, insieme, un invisibile paratesto narrativo, con tanto di figure formali, ruoli attanziali, valori fondanti, etc., inerenti uno specifico corpo sociale, che, in questo nostro caso, è il gruppo musicale dei Måneskin. Un prodotto culturale, ormai internazionale, che, al momento, rappresenta una sorta di punta di diamante tra i recenti output del sistema organizzato dell’industria culturale nostrana.
Ma non solo.
Infatti, come ci testimoniano pure le fotografie dedicate ai Måneskin, le fotografie di gruppo che li raffigurano sono, oltre che una forma di documentazione, anche una forma di astrazione.
Altrimenti detto: una sorta di opera concettuale.
Astrazioni, dunque, media “bizzarri”, come li definirebbe R. Barthes, che fanno circolare “messaggi senza codice”, che mostrano una realtà comunque “intrattabile”.
La loro bizzarria non gli permette comunque di “parlare” senza l’aiuto di un “ventriloquo”, ovvero senza una “voce esterna”. Un altro medium, quindi. Come, ad esempio, un’apparentemente innocua e neutra didascalia esplicativa o un più ampio articolo di supporto. Una condizione di assurdo mutismo, che solo un ventriloquo che “parli” al posto dell’immagine fotografica – importando senso di norma dall’esterno e incollandolo “dentro” l’immagine – le permette poi di “parlarci”. E, “parlandoci”, di rivelarci che in essa è condensata, ad esempio, una particolare storia del gruppo rock della Capitale o altro ancora.

La Fotografia – e questa è una regola d’ingaggio del medium del quale si è obbligati a tenere debitamente conto – è simile a un corpo umano, che esiste e funziona anche grazie e attraverso il contributo di altri “corpi-organi”, ovvero, per quel che qui si tratta, per mezzo di altri media.
Organi di norma “interni”, nel caso del corpo umano. Organi di norma “esterni”, ovvero altri media non contenuti “dentro” l’immagine, invece, nel caso della Fotografia.
Portatori esogeni di senso, che concorrono dall’esterno a “dare una forma” e una “voce” ad ogni immagine fotografica. Un’immagine che vive, dunque, proprio attraverso l’intermediazione della ventriloquia mutuata da altri media, di norma esterni ad essa, è le permettono di “dialogare” con il mondo.
E non c’è alternativa per qualunque tipo di immagine – così come per una qualsiasi altra possibile fotografia che ritragga i Måneskin– per uscire dal loro mutismo congenito, se non ricorrere, come accennato, all’aiuto “esterno” di altri media. Nella “casa di vetro” della Fotografia, “dentro” ogni immagine, in sostanza, non c’è di norma nulla, se non si importa del senso dall’esterno. Tutto o quasi quel senso, la narrazione, i valori, etc., arrivano di solito da un’altra parte, posta dunque fuori dall’immagine. Un altrove, un “fuori”, che, di norma, è dunque tecnicamente estraneo all’immagine. E le fotografie dei Måneskin non fanno, ovviamente, che confermarcelo. Anzi, ne sono proprio, oltre che un’ennesima conferma, una rappresentazione emblematica.
Volendo integrare il discorso e cercare di fare un piccolo esempio riguardo a come funzioni questo meccanismo di iniezione di senso dall’esterno, potremmo tentare di immaginare di realizzare un piccolo esperimento. Potremmo ipotizzare, ad esempio, di descrivere molto sinteticamente la situazione e le possibili reazioni di una persona che ignori persino l’esistenza della Fotografia stessa e, che, per un puro caso, si trovi un giorno per le mani proprio la fotografia dei Måneskin scelta per questo testo. Questa persona, senza l’aiuto del ridetto contributo di senso esterno, non sarebbe verosimilmente in grado di dire granché su chi/cosa sia impresso su questa fotografia né, tanto meno, “tradurre” le persone raffigurate in soggetti formali ai quali dare eventualmente un nome. Soltanto procedendo per gradi e acquisendo progressivamente e preminentemente “da fuori” gli elementi minimi di conoscenza necessari, potrebbe acquisire, dopo un adeguato periodo di “formazione”, gli elementi interpretativi basilari per poter, innanzitutto, comprendere e orientarsi in questo (per lo meno per lui) “nuovo” contesto socioculturale. E, così proseguendo, al termine di questo suo percorso di conoscenza, giungere, magari, alla… “verità”.
Ciò premesso, estremizzando ulteriormente, si potrebbe quindi plausibilmente affermare, senza correre il rischio di apparire troppo radicali, che, senza il più volte citato supporto di senso esterno, nessuno “vedrebbe” nulla di particolare nell’immagine scelta per accompagnare questo testo. Tecnicamente, potrebbe persino non riconoscere nemmeno l’oggetto immagine, ovvero la fotografia, in quanto tale. A conferma della tesi che tutto quel che sappiamo, persino riguardo all’oggetto stesso che costituisce materialmente una fotografia, intesa come supporto visivo, arriva, anch’esso, di norma… da “fuori”.
Attraverso le “pareti” apparentemente trasparenti di qualsiasi immagine potremmo quindi “vedere” la forma e la sostanza del relativo contenuto soltanto se, di fatto, questa ci sono già noti. In altri termini, quel che osserviamo guardando questa fotografia dei Måneskin, non è che quello che, dall’esterno, si “riflette” all’interno della fotografia stessa. In caso contrario, anche la raffigurazione di un corpo noto come quello del gruppo dei Måneskin, come qualunque altra immagine del resto, resterebbe un corpo sostanzialmente insignificante. I Måneskin ci potrebbero eventualmente “parlare” attraverso una fotografia, come si è già detto, non con la propria “voce”, bensì soltanto per mezzo di una protesi significante esterna trasfusa dentro l’immagine da un contesto terzo, estraneo all’immagine e posto di norma “fuori” dalla fotografia originaria stessa. Pertanto, in assenza di aiuti esterni, senza un senso esterno “incollato” dentro la fotografia di volta in volta interessata – per quanto stereotipato possa risultare essere questo significato importato “dentro” – anche queste immagini (persino nel caso di veri e propri cliché) rimarrebbero, in ogni caso, sostanzialmente insignificanti. Senza questo aiuto esterno, non sapremmo, quindi, né quando né dove e perché sia stata mai realizzata, ad esempio, la “nostra” immagine dei Måneskin. Ma non solo, come accennato, non potremmo neanche dare un nome ai (s)oggetti ritratti al suo interno. Non potremmo inoltre estrapolare – al pari di uno sfortunato medico legale impegnato nell’esame post mortem di una salma – nessun dato neanche riguardo alle possibili “cause” dell’evento contingente rappresentato nell’immagine (concerto, intervista, etc.), né, figurarsi, sapere qualcosa di più dei corpi (ancora) anonimi raffigurati “dentro” l’immagine.
La Fotografia, quindi, solo dopo essere stata rifornita adeguatamente di senso importato dall’esterno, diviene quella che tutti conosciamo, ovvero uno strumento e un canale di comunicazione capace di dare (finalmente!) “voce” ai (s)oggetti presenti in un’immagine. Tutti comunque accomunati, senza la ridetta “assistenza esterna”, da una originaria “consegna del silenzio” e dell’anonimato. E di fronte a tanto anonino mutismo, d’innanzi ad un silenzio così “assordante” non è conseguentemente possibile comprendere di fronte a chi e/o che tipo di rappresentazione ci si trovi. All’opposto, invece, con il sostegno simbolico di altri media – sia testi scritti (quali, ad esempi: degli appunti, delle legende esplicative, ecc.) sia “testi” non scritti (altre immagini, testimonianze audiovisive, descrizioni orali, etc.) – ogni eventuale tentativo di “lettura” dell’immagine, prima condannato ad un esito incerto se non persino fallimentare, assumerebbe poi una connotazione di senso più definita e, comunque, ben diversa dal mutismo e dall’anonimato precedente. Si è infine di fronte ad un’immagine “in chiaro” e finalmente “parlante” perché non più orfana di senso. Diverrebbe quindi possibile farne anche un’eventuale ricostruzione indiziaria – o un’autopsia, se si preferisce – più attendibile del “cadavere” visuale che si sta osservando. Si potrebbe, in tal modo, “dare voce”, ad esempio: ai luoghi fisici raffigurati, al senso delle posture delle varie comparse, all’umore generale di un evento e, non ultimo, dare un nome e un ruolo agli stessi protagonisti ritratti (ad esempio: la mamma, il nonno, il compagno di scuola, etc.).
Tra questi “aiuti”, si pensi, come già accennato. in particolare alla potenza espressiva, alla forza d’urto semantico, di norma inavvertita, di una fotografia con o senza una piccola e apparentemente semplice didascalia nella quale ci sia scritto anche soltanto “Måneskin”
(cfr., a puro titolo di esempio, le due fotografie proposte qui di seguito: la prima senza alcuna indicazione e la seconda con la didascalia “Måneskin“).


Un “testo”, la didascalia, che è quanto mai strategico per la sua determinante funzione di staffetta, di orientamento e ancoraggio semantico dell’interpretazione entro confini più o meno definiti. Ci si potrebbe inoltre forse anche chiedere, pur correndo il rischio di alimentare qualche sospetto per una sorta di eccesso di relativismo, se ogni fotografia dei Måneskin, non sia in fondo, come ogni fotografia, del resto, paragonabile a:
- un object trouvéee, quindi, sia probabilmente “imparentata” con i più noti ready made di duchampiana memoria, uno dei prodotti culturali più noti delle c.d. Avanguardie storiche;
- una vera e propria installazione;
- una forma di arte concettuale, intrise della medesima “aura” che caratterizzò la Fotografia, in particolare, nei suoi anni di esordio, ovvero delle forme di arte concettuale ante litteram;
- “voce” di sé stessa, attraverso la didascalia.

Una fenomenologia apparentemente semplice e lineare, quanto, al tempo stesso, articolata e pluridimensionale. Non ultimo, a causa del già detto “ritrarsi” proprio della Fotografia stessa. Un “nascondersi” del medium, che, in sostanza, “fa vedere” all’osservatore solo quello che veicola – ossia l’evento, le persone raffigurate, etc. – senza mai apparire come “veicolo”, come “mezzo di trasporto” e di trasferimento di senso, di pathos dall’esterno del supporto tecnico, all’“interno”. Pathos, che, quindi, non appena questo inserto di valori, idee, emozioni esterne – al pari di un Cavallo di Troia, si sia “insediato” nell’immagine – emerge, quindi, in tutto il suo portato. L’immagine, a quel punto, non è semplicemente un’“immagine di…” qualcosa, ma, “sembra” essa stessa, quel qualcosa, quel soggetto ritratto, quell’evento specifico, etc.
Proprio come sembra che “funzioni” anche la fotografia che accompagna questo testo, che raffigura i Måneskin, durante un’intervista realizzata poco dopo la già citata vittoria al Festival di Sanremo del 2021.
Ciò premesso, quelli ritratti “non” sono, dunque, e non lo saranno mai i Måneskin, benché ci appariranno sempre come tali avendo noi ormai importato dall’esterno, e indentificato e cementato per l’eternità, il senso, il significato, che specificatamente veicolano. Non sono, però, la band romana, per quanto superficiale e banale possa apparire questa affermazione, pur essendo apparentemente “loro”, ovvero una loro “copia”, sotto forma di immagine. Saranno sempre e soltanto un loro simulacro, un loro fantasma, etc.
Un supplente: il loro “riflesso”, impresso in una fotografia.
E, accennando la questione della referenzialità, per maggior completezza, non si può, infine, non evidenziare anche il notevole coinvolgimento emotivo che questi percorsi concettuali tendono ogni volta a generare sia nei diretti interessati sia nei loro “dintorni affettivi”.
Ogni qualvolta vediamo una fotografia, in particolare un ritratto, come ci ricordava R. Barthes, l’immagine non ci lascia mai, in assoluto, del tutto indifferenti, producendo un diverso gradiente di emozioni, una miscela variabile di sentimenti e sensazioni che dipendono da una varietà di fattori: circostanziali, affettivi, temporali, ideologici, etc.

“La camera chiara” di R. Barthes offre, anche al riguardo, diversi spunti memorabili.
Esaminando questa immagine dei Måneskin (o uno dei suoi particolari), sebbene ancora una volta superficialmente e sommariamente, è stato quindi possibile constatare anche la forza evocativa trasversale e l’emblematicità di questi “surrogati” del reale che chiamiamo comunemente Fotografia. Rimpiazzi visuali dei corpi originari che, oltre il “ritrarsi” e la relativa “invisibilità” che li accomuna alla Fotografia generalmente intesa, condividono con questo medium anche un altro elemento strategico: la cornice.
La cornice è un ulteriore elemento formale e, insieme, un altro corpo nel corpo, talora anche un corpo significante a sé stesso. Un delimitatore formale, dunque, del perimetro “politico”, del raggio d’azione e d’interesse del senso veicolato dall’immagine che delimita. Una delimitazione perimetrale che sussiste, si badi bene, persino quando non sia formalmente ben delineata e non ci appaia, quindi, in modo chiaro e netto. Eserciterà, sempre e comunque, tutto il suo potere formale anche in nei casi nei quali risulti indefinita e poco o per nulla tangibile. La cornice incarna, quindi, anche quando non si vede, una sorta di recinto sostanziale. Un baluardo, un apparato di protezione, un presidio di appartenenza. Uno spartiacque tra il “dentro” e il “fuori”. Una specie di muro di cinta – di confini reali o immaginari – posto a custodia, controllo e difesa del contenuto di senso “interno” all’immagine rispetto a tutto il resto che in quel frangente formale e/o temporale viene o deve essere isolato all’esterno.
Essa è una sorta di check point “sorvegliato” – dall’intento dell’autore, ad esempio – dove viene controllato ogni possibile elemento di senso eventualmente in transito tra l’esterno e l’interno dell’immagine e viceversa. Un varco e, insieme, un ponte fra le due dimensioni di senso e la relazione dialettica tra l’interno dell’immagine con quanto è e veicola significato al di fuori di essa.
Ed è, pertanto, proprio questo reticolato difensivo che ci consente di affermare e confermare che l’immagine che accompagna questo testo è una fotografia dei Måneskin e non di un qualunque altro differente (s)oggetto reale o immaginario.
Si tratta, in altri termini di una dialettica di norma sempre molto accesa e non di rado anche ferrea e radicale. Una contesa semantica incessante e per nulla bonaria. Tutt’al più, nelle sue forme migliori, può apparire come una contrapposizione in forma “benigna”, meno estrema, per lo meno in apparenza, per lo meno in superficie. In ogni caso, è una contrapposizione ineliminabile, incessante e, comunque, strategica per garantire l’intangibilità del senso acquisito (almeno “sino a nuovo ordine”, come, ad esempio, una risemantizzazione parziale o totale del significato contenuto “dentro” l’immagine). Una interrelazione strategica, dunque, perché, senza di essa, l’interno dell’immagine non potrebbe avere né un senso “certo”, così come, all’opposto, l’esterno non potrebbe, ad esempio, confermare e consolidare la relativa dimensione significante. Un senso che si nutre, si arricchisce e si consolida vicendevolmente, proprio grazie alla relazione bellicosa, alla “guerra” tra ciò appare essere “dentro” e ciò che sembra essere rimasto “fuori”. Un confronto dialettico, senza sconti, tra elementi diversi, i quali, con gradienti e in una relazione sinergica di volta in volta eventualmente anche variabile contribuiscono a definire lo scarto di senso, la relazione gerarchica e funzionale, etc. tra ciò che si ritiene sia “dentro” e ciò che, invece, è “fuori”. Ė questo, in sostanza, il contenuto di senso che custodisce e difende nei suoi confini, nel suo perimetro – formale o, talora, anche soltanto immaginario e/o ipotetico – un’apparentemente semplice ed innocua cornice.
Ancora una volta, anche la “nostra” fotografia che ritrae i Måneskin, analogamente a qualsiasi altra eventuale immagine – e non sembri eccessivo ribadirlo nuovamente – non fa ovviamente eccezione a questa regola.

Per la fotografia di un preservativo, piuttosto che di un clistere o di un’astronave, così come, appunto, anche per questa immagine dei Måneskin, vale inoltre la riflessione – sempre di R. Barthes – che evidenzia un’altra delle caratteristiche distintive della Fotografia, ovvero il suo potere di autentificazione. Un potere di autentificazione che mette in subordine quello di raffigurazione. Raffigurazione attraverso la quale la Fotografia “registra” a suo modo l’essenza visiva del mondo. Un’essenza visiva che, per quanto differita a livello temporale, supera la mera riproduzione del reale, andando oltre. Un andare oltre che ripropone il passato presentandolo addirittura “al presente”. La Fotografia, in questo caso, in questa istantanea dei Måneskin, diviene, in tale prospettiva, una specie di fabbrica di spettri, producendo ininterrottamente soltanto una sorta di corpi fantasma. I corpi fantasma dei componenti della formazione rock oggi singolarmente fonte di orgoglio nazionale, che adesso, domani e finché durerà, ci sembreranno paradossalmente immersi in un eterno presente fittizio. Un presente ipotetico, dunque, quanto immutabile e senza futuro, del quale la Fotografia ci mostra perennemente il “cadavere” del corpo del relativo referente originario. Attraverso questa ostensione nella “camera ardente” raffigurata in ogni immagine, la Fotografia alimenta l’emergere di una dimensione straniante, dove il “reale” è sempre assente. Una sorta di trip ipnotico e, a tratti, tendenzialmente anche psichedèlico, in forma di fermo immagine. Un “viaggio” allucinante per il quale non occorre fare né una prenotazione né comprare alcun biglietto, pur non essendo affatto né gratuito nè, tanto meno, indolore. Un sentiero narrativo comunque insidioso, sebbene sia percorso senza aver necessariamente assunto alcol e/o sostanze psicotrope. Un “reale” scomparso e sostituito soltanto da simulacri visivi. Una specie di follia percettiva, una vera e propria allucinazione visiva che – attraverso questo medium “folle” che chiamiamo Fotografia – offre allo sguardo, in quest’occasione, i “corpi” ormai svaniti dei Måneskin. Corpi culturali, fantasmi di un’idea di qualcosa, di qualcuno, virtualmente reificati e resi presenti… “al passato”. Ne deriva, ha sintetizzato ancora una volta R. Barthes, che:

“La Fotografia diventa allora […] medium bizzarro, una nuova forma di allucinazione: falsa a livello della percezione, vera a livello del tempo.”
Ogni immagine, compresa quella presa qui a pretesto, è per sua natura sempre una paradossale rappresentazione di secondo grado che, nella migliore delle ipotesi, può far presupporre – senza comunque poterlo garantire con certezza assoluta – un eventuale rapporto con un altrettanto eventuale referente originario, una possibile fonte concreta, “reale”.
Un collegamento, una relazione ipotetica, dunque, tra un prima e un dopo, tra un originale e una sua (im)probabile copia, che, inevitabilmente, sfocia in un’altra potenziale paradossalità. Una paradossalità generata dalla coesistenza nell’immagine-copia, come emblematicamente avviene in ogni fotografia, di un (s)oggetto comunque altro, differente dall’originale, seppure nell’apparentemente indistruttibile vincolo di verosimiglianza con l’analogo originario. Un’assurdità insita in ogni immagine – fotografie comprese, ovviamente – proprio a causa dall’amalgama in ciascuna di esse di un’immagine altra, diversa e comunque anche temporalmente più o meno distante, del suo apparente (s)oggetto originario. L’idea diffusa della verità come presunta somiglianza fedele tra una rappresentazione e il suo referente, forse in nessun ambito è così tanto pregnante e insistente come nel mondo delle immagini. Anche in questa fotografia dei Måneskin, dunque, così come in qualsiasi istantanea – la Fotografia tout court, secondo un punto di vista diffuso e condiviso che la considera “il” vero ed inossidabile “duplicato” del reale – questa emblematica questione sembra riecheggiare in maniera ancor più evidente perché non offre, in assoluto, alcuna risposta che dia una certezza definitiva. Questa indeterminatezza è ovviamente ulteriormente amplificata nel caso di immagini che hanno l’eventuale “sfortuna” aggiunta di non riprodurre fedelmente, in modalità tecnicamente più “nette”, le apparenze del relativo referente originario. Del resto, se così fosse, ovvero se la copia fosse “come” l’originale, non esisterebbe alcuno scarto tra la copia e l’originale e non vi sarebbe quindi più alcuna differenza tra di loro. Saremmo, piuttosto, di fronte a un fenomeno dalle connotazioni paranormali – oggigiorno, quanto meno, poco credibile – di ubiquità e/o, per lo meno, di sdoppiamento.

Incredulità a parte, si tratta di una questione, questa della verosimiglianza della riproduzione rispetto alla realtà originaria che non si presenta sempre in modo così netto ed estremo. Prendiamo sempre ad esempio la “nostra” immagine dei Måneskin, ovvero, in questo caso, una sua versione “artistica”, realizzata con un comune e popolarissimo photo-editor per immagini (cfr. qui sotto).

In questo caso specifico, così come, più in generale, nell’ambito artistico più autentico, la questione della verosimiglianza perde o, comunque, cambia in maniera significa la sua prospettiva. Arriva persino a perdere del tutto, senza perdere, per questo, il suo valore come prodotto artistico, quella strategica sua qualità riproduttiva, quel valore sacro, positivista, scientifico di “specchio del reale”, che, invece, sembra tenacemente ancora poter e voler in ogni caso possibile affermare. Un tale mutamento di prospettiva può essere legato, per esempio, ad un aspetto “funzionale”. Ovvero, sempre per fare solo un possibile esempio, perché un autore, piuttosto che ricreare ad ogni costo il “reale”, può, per così dire, “sacrificare”, sostituendola con qualcos’altro. Come, ad esempio con una dimensione altra, che tenda a trascendere il reale concreto al quale fa eventualmente e magari vagamente riferimento l’immagine (ad esempio un quadro, una scultura, etc.). Si tratta, senza fare del relativismo banale ed eccessivamente semplificante, di una dimensione differente, non di rado caratterizzata dalla visionaria “inattualità” di chi immagina qualcosa talvolta persino senza aver mai prima visto e conosciuta la “realtà” che riecheggia nelle opere che poi realizza. La compresenza, inoltre, del dato originario e di un relativo piano concettuale nelle relative copie rende ancor più critici i rapporti di dipendenza tra queste differenti dimensioni.
Non per questo, si è accennato, un’opera così prodotta rischia di valere eventualmente di meno. Tutt’altro, come spesso l’Arte moderna ci ha dato modo di constatare. E, tentando di fare un altro esempio possibile, e radicalizzando solo in apparenza il discorso, potremmo provare ad applicare questo teorema probabilmente male espresso, anche ai prodotti “istituzionali” dei Måneskin, ossia: alla loro musica, alle loro canzoni. Anch’esse delle immagini in fondo, sebbene sotto altre forme sintattiche ed espressive. E, sempre in proposito, rievocando forse maldestramente il lessico del linguista e semiologo svizzero F. de Saussurre, da un punto di vista tecnico, potremmo probabilmente definire come delle “immagini acustiche” – il c.d. “significante” – le creazioni, le parole e la musica poi “verbalizzate” dai Måneskin: l’esito, “a valle”, delle loro ibridazioni arbitrarie con il relativo patrimonio di senso posto “a monte” (il “significato”).
Immagini anche queste, dunque, sebbene “sotto copertura”, infiltrate e riemergenti a tratti tra musica e parole. Queste ultime, le parole, anch’esse, per quanto “travestite”, comunque delle “immagini” (sonore).
Immagini, in ogni caso, dunque, che sono sempre una “immagine di”, ossia un’immagine di qualcosa che rinvia comunque alla propria origine. Analogamente, non si ha un’immagine se non si “ricalca” una qualche realtà altra di idee o di (s)oggetti. In altri termini, se la realtà non fuoriesce da sé stessa e non crea qualcosa che è altro da sé. E la riproduzione, la provenienza e la discendenza costituiscono, quindi gli ambiti metaforici di riferimento privilegiati per ragionare intorno alla creazione di un’immagine, dato che ogni riproduzione tende comunque a creare un’indissolubile “consanguineità” con la fonte originaria e, così facendo, pone le basi per la creazione di un’ulteriore immagine, ovvero la suaccennata: “immagine di”. Queste immagini sembrano quindi ricordarci – ancora una volta, nel caso ce ne fosse bisogno – che anche la fotografia dei Måneskin in argomento, come qualsiasi altra immagine, non si fonda sostanzialmente mai, in fondo, su “punti fermi”. Anch’essa è circondata di fantasmi, simulacri, tracce labili, nel caso migliore di semplici apparenze. Non esisterebbe, quindi, più nulla di certo, tanto meno una sola verità, bensì, per quel che possono servire, delle eventuali, possibili “versioni” di quest’ultima. L’idea di verità, in questo ordine di idee, è divenuta una sorta di chimera inafferrabile. In altre parole, la verità diviene un’apparenza, peraltro momentanea, tra tante altre ugualmente ipotizzabili. Per di più, si tratta di un’apparenza senza più alcun valore. Anche la verosimiglianza dell’immagine fotografica con il corpo originario del quale sarebbe un’eventuale copia, alla prova di fatto si dissolve nel nulla.
Sopravvive solo una sorta di intento visionario.
Un sogno più profondo, più intenso, che tenta di trasformare un impossibile in un non incredibile. E la cennata verosimiglianza dell’immagine fotografica – che prova schizofrenicamente a tentare di rendere verosimile l’inverosimile, tentando di “dare forma” di verità e di concretezza al nulla – è soltanto pura immaginazione.
È, in generale, il paradosso ingannevole veicolato da qualsiasi immagine.
Un paradosso, si ribadisce, ulteriormente accentuato nella Fotografia che, come in una sorta di gioco perverso, sembra poter garantire il massimo della verosimiglianza anche quando, in realtà, offre soltanto il massimo della finzione.
In quest’ottica la riproduzione della “realtà” è in subordine.
Un supplente, ossia una sorta di “verità mimetica” del (s)oggetto originario.
Un’astrazione e uno slittamento concettuale che cambia lo status dell’immagine, compresa quella dei Måneskin, in sinèddoche e/o metonimia piuttosto che analogon.
Un analogon che prende a prestito dalla concettualizzazione una possibile veridicità che rinvii a quanto denota o significhi.
Una concettualizzazione che mette in relazione il processo interpretativo delle immagini con l’ambito linguistico.
Un percorso interpretativo che rinvia al c.d. nominalismo, secondo il quale il collegamento tra segni e significati, andando oltre la derivazione dall’originale, come già accennato rievocando il linguista elvetico F. de Saussurre, è essenzialmente e sostanzialmente di tipo arbitrario. Ciò nonostante, secondo l’analisi semiotica la doppia idea che convive in ogni segno, ovvero quella del rappresentato e della sua rappresentazione, tenderebbero a conservare un inevitabile legame con il segno naturale pur nell’indispensabilità del segno artificiale. Un segno artificiale, distinto dal (s)oggetto originario, ma irrinunciabile per la raffigurazione. Una raffigurazione, magari insoddisfacente, perché oscilla tra un’icona e un feticcio, che, in ogni caso, veicola il “corpo” dell’immagine che il destinatario finale poi osserverà. Una mimesi contrastante, posticcia, finanche antitetica, insita in ogni immagine, dunque. Un contrasto non riducibile alla sola divergenza fra una rappresentazione simile o dissimile, dato che ogni immagine può tendenzialmente conservare qualche eventuale segno della forma, delle fattezze del “modello” originario.
La fotografia dei Måneskin in questione, seppur rielaborata, ne è una rappresentazione, fra le tante comunque possibili, e, in ogni caso rappresentativa e, insieme, emblematica.

Quindi, almeno in superficie, almeno in apparenza, in ogni riproduzione, fotografia dei Måneskin inclusa, continua comunque incessante a riverberarsi il referente originario.
All’opposto, l’eventuale prevalenza della non somiglianza determina una frattura irreparabile tra l’immagine finale e il relativo referente di provenienza. In questo caso, per creare un eventuale relazione con il (s)oggetto originario, l’immagine rinvia all’accennato nominalismo. A seguito di questo trasferimento interpretativo, l’immagine da ontofanica diviene semiologica.
Una dimensione interpretativa che, anche accettando l’eventualità dell’obiettività della raffigurazione rispetto al suo referente originario, tende generalmente ad associare l’interpretazione ai ridetti fatti arbitrari, analogamente a quanto avviene anche con la scrittura e la parola. L’immagine diviene, pertanto, un segno che non ha più una relazione ontologica con il “corpo” del suo referente originario.

Scriveva al riguardo J.-J. Wunenburger:
“Nel segno, l’immagine rinvia in modo convenzionale a una certa identità rappresentativa che le è connessa, in quanto il rappresentante o il significante assicurano prima di tutto una funzione denotativa. Nel simbolo, il nesso significante-significato fa appello a un metalinguaggio che arricchisce il senso proprio con un senso figurato.”
Ognuna di queste mimesi, inoltre, ognuno di questi “corpi” fotografici – rievocando l’ipotetica creazione di una realtà secondaria, sostanzialmente, una finzione – rinvia inevitabilmente anche al celebre mito della caverna di Platone. Un mondo irreale, una realtà immaginaria, che, di nuovo, rende particolarmente critica la relazione di quello che l’immagine mostra con il referente originario. Un universo visivo fittizio, un’astrazione concettuale alla quale può risultare talora arduo attribuire lo status di traccia (sensibile), talora persino di un eventuale, possibile collegamento con l’esistente, con il “vero” originario. Un altro da sé che non è una semplice, “passiva” raffigurazione, ma, all’opposto, è sempre una rappresentazione “attiva”, un medium attraverso il quale si riordina instancabilmente il proprio universo simbolico. Un’attività incessante e onerosa nella fitta, intricata e immensa foresta di segni e di senso che connota quest’era della relatività del visibile. Un reticolo significante nel quale è convenzionalmente consigliato tentare di interpretare ogni segno come parte di una teoria di galassie di senso con la consapevolezza, già accennata, che, piuttosto che certezze, potrebbero invece risultare soltanto innumerevoli potenziali verità più o meno latenti. Tra queste, quella relativa alla tratteggiata questione mai definitivamente conclusa relativa alla capacità – o meno – della Fotografia di “duplicare” il reale. La “verità” che ne emergerebbe, tenendo conto dell’accennata perenne dissonanza tra raffigurazione finale e la fonte originaria, confermerebbe non tanto quanto la Fotografia sia in grado di riprodurre il “reale”, bensì proprio l’esatto contrario, ovvero l’impossibilità assoluta di replicare la “realtà”.
In questa “tara”, in questo “handicap”, risiede la paradossalità anzidetta e, insieme, l’inquietudine e l’incessante fascino della Fotografia.
“Attrazione fatale” che, in questo caso, si è concentrata su questo ritratto informale dei Måneskin.

All’opposto, come si è già accennato precedentemente, un disegno, una scultura, un quadro, pur mostrando apparentemente una forte somiglianza con cosa riproduce, emerge e si mostra sovente se non sempre per quel che è una connotazione specifica, ovvero che si tratti di un artefatto e che la sua, connaturata, natura è soggettiva e, dunque, soltanto, eventualmente rappresentativa. La Fotografia, al contrario, incluso questo fotogramma dei Måneskin, sorprende e stupisce sempre allorché “si scopre”, come si è dichiarato precedentemente, questa eventuale natura soggettiva e rappresentativa.

Una “scoperta” finanche straniante di fronte ad un medium che, sebbene tenti incessantemente di creare dei legami con il reale concreto, in assoluto, non vi riesca affatto. L’aspirazione di fondo della Fotografia può essere quindi reindirizzata nella demiurgica e comunque strategica rappresentazione secondaria del mondo. Una “realtà” di secondo grado che, almeno apparentemente, sembra “vera”, come se fosse un reale di primo grado.
Anche per tali ragioni, secondo M. Cacciari il mondo della Fotografia è un mondo “tutto umano”. Un “corpo” artefatto (ri)creato di sana pianta dagli esseri umani, perfettamente in linea con l’aleatorietà e l’astrattismo dei nostri tempi.
Considerazioni, anche queste ultime, che riguardano, per quanto ovvio, anche la casa di vetro simbolicamente condensata, come quella qui presa non analiticamente in esame, in ognuna delle tante altre fotografie dedicate a questo gruppo musicale e, più in generale, alla Fotografia stessa.

Una casa di vetro anch’essa comunque “bizzarra”, perché, come accennato, attraverso le sue pareti “trasparenti” ci mostra o, meglio, “riflette”, al pari di un’allucinazione, non l’interno ma l’esterno. Un mondo esterno, una contaminazione aliena, che, metaforicamente, comprende anche chi osserva, con tutto il suo bagaglio di senso, valori, etc.
Una sorta di subdolo Cavallo di Troia, si è detto, che, una volta entrato entro le mura di cinta del (s)oggetto “significante”, se ne impossessa e, prendendone il controllo, veicola poi senso di norma importato dall’esterno, piuttosto che dall’interno dell’immagine.
Un’invasione e un compromesso che la Fotografia “deve” in ogni caso accettare, perché, come si è detto più volte, senza questa infrastruttura esogena di senso, potrebbe restare irrimediabilmente anonima e muta. Magari intrisa anche di Bellezza, come altrettante immagini dei Måneskin, ma, comunque, silenziosa e senza… senso.
Roma, 8 Febbraio 2022
Tutte le immagini: Anonimo, Måneskin, 2021 (elab. G. Regnani) tranne per le foto 12 e 13 che sono di esempio specificato nel testo.
LA “GUERRA” DELLA FOTOGRAFIA
Roberto Saviano e la fotografia come testimonianza e prova.
Gerardo Regnani nato il 25-07-1963 a Frauenfeld (Svizzera)
Sposato con figli da circa metà degli Anni ’90 vive stabilmente a Roma. L’interesse per la fotografia, frequentata negli anni attraverso vari percorsi (ricerca, analisi, critica, autoriale, divulgativo, espositivo, etc.), si è via via consolidato, a partire dalla prima metà degli Ottanta del ‘900, e prosegue tuttora. Negli anni più recenti, ha assunto una dimensione di maggior rilievo l’analisi del “corpo” poliedrico della fotografia, fatto di riflessioni sulle teorie, la storia, gli autori, le immagini, le tecniche, le interazioni simboliche, le pratiche di fruizione e gli statuti di questo strategico medium tra i media.
Alcuni incontri fondamentali durante questo cammino sono stati, tra gli altri, quelli avuti durante la frequenza, c/o l’Istituto Superiore di Design in Torino, del corso biennale di fotografia (1991-92), la partecipazione alla fondazione dell’Associazione culturale FINE (1998)(*) e, non ultimo, la Laurea in Scienze della Comunicazione c/o l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2005, con una tesi sulla fotografia, relatore il prof. Alberto Abruzzese, co-relatore il prof. Jacobelli.
Ha esposto: “Persone & figure” – Famija Moncaliereisa – Moncalieri (To), 1995“Foto esordio 1997” – Università di Roma Tor Vergata, a cura del Mifav, 1997“Incontri” – Maison des Arts – Bages (Aude) – Francia, 1999“A mia figlia” – Personale – Spazio FINE (Docks Dora) Torino, 1999“Incontri/Rencontres” – Centre Méditerranéen de l’Image – Château de Malves – Malves-en-Minervois – Francia, 2001“Sguardi e immagini” – Istituto Nazionale per la Grafica, Palazzo Fontana di Trevi – Roma, 2001“Un ponte per Baghdad” – Libreria Odradek – Roma, 2002“ Confine” Spazio FINE (Docks Dora) Torino, 2002“QPN” Nantes – Francia, settembre 2003“Confine”, Cuneo, 2004“Prometeo”, Roma, 2006“Avec Mazzino”, Maison des Arts – Bages (Aude) – Francia, 2007“Metafore”, Messaggi d’arte, 2008 “La casa. “Interni”, Francia, 2018.
iniziative – progetti – collaborazioni Co-promotore del Gruppo FINE (Fotografia e Incontri con le Nuove Espressioni), 1998Co-fondatore dell’Associazione culturale FINE, 1998Co-curatore dello Spazio FINE, Torino, 1998-2002Responsabile e curatore “Collezione FINE”, dal 2006 in poiRivista “F&D”, Mifav (Museo dell’Immagine e delle Arti Visuali, Università di Roma Tor Vergata), 1995-2002Università degli Studi di Roma “La Sapienza”Dipartimento di Sociologia e comunicazione – Media education, Roma, contributi, 2004, MIT Technology Review, contributo, 2005, MediaZone, rivista on line della Facoltà di Scienze della Comunicazione – direttore: M. Morcellini – contributi, 2005-2008, Cattedra di Analisi dell’Industria culturale (M. Morcellini) – ciclo di incontri: “La fotografia: medium tra i media”, 2007-2008Cattedra di Analisi della narrazione audiovisiva e dell’immaginario – supervisione della tesitesi “Radioscia. La fotografia alla radio” di S. LichtmanneggerNIM, Newsletter Italiana di Mediologia – direttore: A. Abruzzese – Contributi, 2007-2008Allestimento mostre, 1998-2002“, Social network e Fotodinamismo. La fotografia (im)mobile”, Convegno internazionale “Eredità e attualità del Futurismo”, Centro culturale “Elsa Morante”, Roma, 11-12 aprile 2013Recensione testi sulla fotografia: storia, semiotica, comunicazione, monografie, raccolte, mostre, dal 1990 in poiTesti critici per diversi autori, dal 1990 in poi.
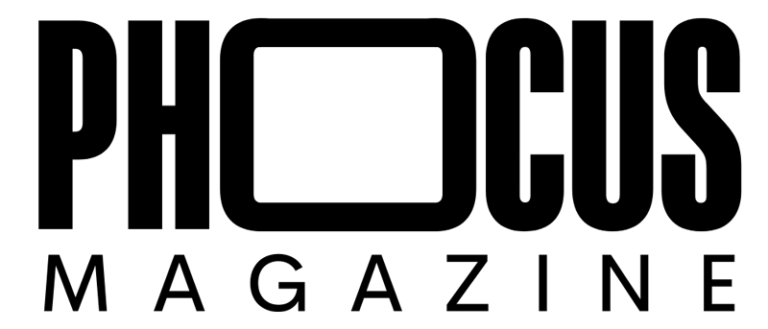
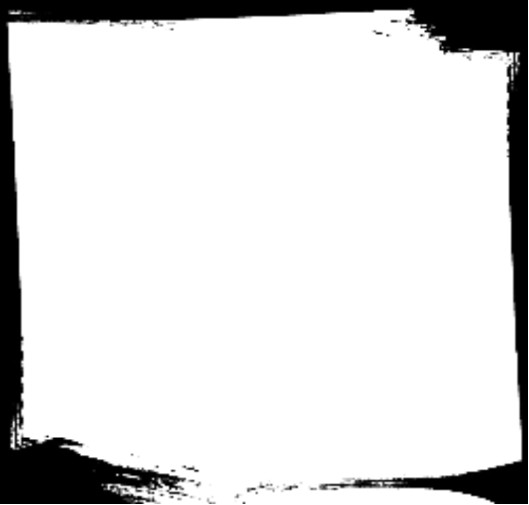

No comment yet, add your voice below!