“Penso che la fotografia sia un po’ come il bellissimo movimento singolo che fa un calligrafo giapponese. Una pennellata che racchiude tutto”. Il fotografo italiano Paolo Pellegrin parla apertamente della sua notevole carriera e di come il sistema EOS R gli permette di rimanere fedele alla sua arte.

Il fotoreporter italiano, membro di Magnum Photos e Canon Ambassador Paolo Pellegrin ha trascorso decenni a documentare conflitti e crisi in tutto il mondo, dall’Uganda e la Bosnia alla Striscia di Gaza, la Cambogia, Haiti e altro ancora. Ha ottenuto l’ammirazione di tutto il mondo, tra cui 10 World Press Photo Awards, ma rivela che per lui il processo fotografico è ancora una lotta: con la realtà, la storia, il soggetto, il contesto e con sé stesso.
Nel 2018 ha messo alla prova l’allora nuovo sistema Canon EOS R per le strade di Tokyo e nella meno conosciuta penisola di Noto, seguendo uno dei principi guida della street photography: “accetta tutto ciò che incontri”. Paolo passava 14 ore al giorno a camminare per le strade con un caldo soffocante e a fotografare tutto ciò che catturava la sua attenzione: persone, riflessi, livelli.
“La fotografia di strada è il campo di battaglia di ogni fotografo”, spiega. “È il luogo in cui si inizia a dare un senso al rapporto tra sé stessi, il mondo e la fotocamera, e a come usare questo strumento per catturare frammenti di realtà. Penso che se sei un buon fotografo di strada, sei un buon fotografo”.
La capacità di osservare un ambiente cinetico, la velocità e l’accuratezza tecnica sono abilità che sono servite a Paolo quando ha documentato i conflitti in cui ha creato alcune delle sue immagini più toccanti. Ma non ha sempre adottato lo stesso approccio nel suo lavoro. “Ho passato molti anni, direi circa 20 anni della mia carriera fotografica, a cercare di fare un tipo di fotografia additiva”, spiega. Si trattava di cercare di dare profondità a ogni fotogramma, creando composizioni molto articolate in cui accadevano più cose. È un tratto distintivo di molti fotografi di strada di rilievo, tra cui il leggendario Henri Cartier-Bresson. Paolo sosteneva l’idea bressoniana che “un’immagine debba essere “risolta” nella fotocamera al momento dello scatto”.
“Cercavo di creare le condizioni per me stesso e per lo spettatore di viaggiare all’interno di una singola immagine”, afferma Paolo.
Ora adotta un approccio diverso: quello della sottrazione. “Sei alle prese con molte cose diverse”, spiega Paolo. In breve, elimina il superfluo fino a raggiungere “l’essenza” dell’immagine. “Penso che la fotografia sia un po’ come il bellissimo movimento singolo che fa un calligrafo giapponese. Una pennellata che racchiude tutto”. Un luminoso crepaccio da cui fuoriesce della lava in uno scuro paesaggio vulcanico, per esempio, o un iceberg imponente le cui estremità sembrano dissolversi nel cielo grigio che lo circonda.

Il modo di lavorare e di vedere di Paolo
In un profilo sul New Yorker, lo scrittore Ben Taub ha osservato Paolo mentre delle chiazze di luce attraversavano il deserto del Namib, nell’Africa meridionale. “Ha smesso di parlare e sollevato la fotocamera, come mi aspettavo, ma nei momenti di intensa concentrazione sembra un’altra persona. Ha lo sguardo fisso, le labbra un po’ arricciate. Si muove deliberatamente, in silenzio, con la testa che scruta la scena, non in modo fluido ma con movimenti bruschi, come quelli di un rapace”, scrive Ben.
L’elegante semplicità dell’immagine risultante contraddice questo processo. “A volte questa esperienza si impadronisce di te, per questo si nota anche una trasformazione fisica”, spiega Paolo. “È come se tutti i tuoi sensi diventassero più acuti e consapevoli, continui a scattare e a muoverti. Cerchi di darle un senso”.
Per Paolo, la fotografia è nella mente. “È lì che metto tutto il mio impegno”, dice. “Mi interessano molto le fotografie che riguardano qualcosa di specifico ma che evocano anche qualcosa di più grande, universale o metaforico”. Paolo ha notato che una fotografia ha più successo solo quando comunica su più livelli e “quando evoca la condizione di rifugiato, la condizione di animale selvatico”.
In termini di tecnica e composizione, Paolo cerca di risolvere ciò che ha di fronte nel modo più semplice. “C’è un’intera palette o gamma di opzioni che la fotografia offre e che può aiutarci a trasmettere un significato, ma sento anche che a volte si corre il rischio di applicare una formula”, afferma. “Sono piuttosto deciso a non volerlo fare”.
Quando la luce naturale era assente, lavorava con le torce. “Funziona ma, per fare un’analogia con la scultura, sono a un punto in cui voglio togliere il più possibile per raggiungere il nucleo, l’essenza”, sostiene. “La semplicità è davvero l’obiettivo finale, eliminare il superfluo”. È per questo che preferisce l’oscurità.

Il confine tra il visibile e l’invisibile
Molte delle immagini di Paolo sembrano emergere dall’ombra. Il confine tra il visibile e l’invisibile esercita su di lui un fascino particolare. I flussi di lavoro e le tecnologie digitali offrono qualcosa di “straordinario”: la possibilità di sperimentare con la scarsa illuminazione o la quasi totale assenza di luce. “Ho l’idea che le cose siano velate e che le si possa tirare fuori dall’oscurità”, spiega. “Ogni volta che c’è del buio, la mia fotografia viene accentuata”.
Paolo pensa che il suo apprezzamento per la scarsa illuminazione possa essere il risultato del fatto che da ragazzo veniva trascinato in diverse chiese dal padre architetto. Durante queste visite, ha imparato ad apprezzare l’aspetto essenziale di una o due fonti di luce, come una retroilluminazione o una luce laterale, che creano forme e motivi.
Nato a Roma nel 1964, Paolo progettava di diventare architetto ma, al terzo anno di università, la sua vita ha preso una piega diversa. “Un giorno ho avuto un’illuminazione e ho capito che non era quello che volevo fare”, racconta. Ha lasciato gli studi e la sua “vita è cambiata da un giorno all’altro”, e lui ha abbracciato questo cambiamento.
“L’analogia che ho sempre fatto e che faccio tuttora è quella con una lingua straniera: la fotografia è un’altra lingua che devi imparare”, ricorda. “Devi imparare la grammatica, la sintassi, le parole e metterle insieme. Ho studiato il vocabolario della fotografia attraverso i libri e poi sono uscito, ho scattato, ho sviluppato di notte e ho sperimentato. Mi ci sono voluti almeno otto o dieci anni per sentirmi un esperto di questo linguaggio”.
Ma il processo non si è fermato qui perché, come spiega Paolo, non finisce mai. “È questo il bello della fotografia. La nostra visione fotografica continuerà a cambiare con le nostre esperienze e con il tempo”.

Cambiamenti tecnologici
Durante il suo periodo di lavoro nel settore, Paolo ha visto la fotografia subire grandi cambiamenti con l’avvento della tecnologia digitale. “In passato, dovevi avere delle nozioni tecniche su come esporre la pellicola, sviluppare un negativo o stampare”, racconta. “Erano cose che dovevi imparare e padroneggiare”.
Oggi, invece, il processo fotografico è più accessibile, ma la meccanica non è cambiata, secondo Paolo. “Si tratta di impegno, di tempo, di empatia”, afferma. “C’è chimica, personalità, cultura e tutto quanto viene misteriosamente distillato nella fotografia e nella narrazione. La complessità di questo processo non è cambiata”.
A differenza di altre discipline, la fotografia progredisce con la modernizzazione e l’avanzamento della tecnologia digitale, tra cui il pluripremiato sistema EOS R di Canon, che ha permesso ai fotografi contemporanei di esplorare un mondo che i loro predecessori non hanno avuto l’opportunità di scoprire.
“Ci permette di superare ciò che prima era un ostacolo, ovvero l’oscurità”, afferma Paolo. “Puoi scegliere ISO12.500, ISO24.000 o ISO56.000 e scoprire un mondo in cui prima non si poteva entrare”.

Un ripensamento
La ricerca della semplicità di Paolo si applica anche alla scelta del kit. Per molti anni ha scelto obiettivi a focale fissa. “Era la mia idea di obiettivo puro e, per usare le parole del regista d’avanguardia cileno-francese Alejandro Jodorowsky, la ‘danza della realtà’, in cui bisogna muoversi e interagire con lo spazio e il soggetto”, racconta. “Il movimento è un processo mentale e per molti anni mi ha appassionato molto. Devo dire che Canon RF 28-70mm F2L USM, però, è talmente straordinario che è diventato il mio obiettivo principale”.
L’entusiasmo di Paolo non si limita a questo obiettivo zoom in particolare. Infatti, consiglia la gamma del sistema EOS R nella sua interezza. “Sono un grande fan della fotocamera EOS R5. È proprio perfetta per me”, osserva. “È la prima volta dopo tanto tempo che trovo dei file che mi soddisfano davvero. Tengo davvero a questo dispositivo più che ad altre fotocamere da molti, molti anni: mi piace tutto, i file, l’ergonomia, gli obiettivi”.
C’è una caratteristica al di là della sua scheda tecnica che ci tiene a far notare. “L’affidabilità è una vera e propria virtù. Il fatto di avere uno strumento su cui poter contare sempre è una cosa importante”, sostiene.
“A volte ci sono cose, oggetti, macchine o altro, che senti rispecchiano davvero te e la tua visione. Io l’ho provato con questa fotocamera” sostiene.
Ritorno nelle zone di conflitto
Nel 2018, Paolo è stato protagonista di un’ampia retrospettiva nella sua città natale, Roma. Intitolata “Un’antologia”, ha raccolto più di 150 fotografie e opere inedite che riflettono i temi sfaccettati del suo lavoro: storie che vanno dall’evoluzione del paesaggio antartico alle zone di conflitto.
Paolo ha pensato, all’epoca, che i suoi anni a occuparsi dei conflitti fossero finiti. “Non voglio parlare tanto del rischio personale”, spiega. “È una mia responsabilità e una mia decisione, ma è una realtà che le guerre sono luoghi pericolosi. Se lo fai un certo numero di volte, per un certo numero di anni, [devi iniziare a considerare] le probabilità”.
Non molto tempo dopo, il mondo è cambiato e, per la prima volta nella sua carriera, Paolo si è tenuto lontano dalla prima linea, scegliendo di rimanere con la sua famiglia durante la pandemia di Covid-19. Ma lo scoppio della guerra in Ucraina lo ha richiamato. Sembrava troppo rilevante, troppo importante.
Paolo è stato in una zona di conflitto per l’ultima volta nel 2018, con Canon EOS 5D Mark IV come fedele compagna. In Ucraina, è stata la capacità di scattare in silenzio con Canon EOS R5 a dare il meglio di sé. “Ci sforziamo sempre di essere invisibili, di essere meno presenti, di interferire poco con la situazione”, afferma. “Credo che la modalità silenziosa, in molte circostanze, cambi davvero le carte in tavola”.
Tempo limitato e concentrazione
Che si tratti di accettare la sfida di realizzare ritratti di celebrità per il New York Times, di commissioni per la F1 o di spedizioni del National Geographic, Paolo cerca continuamente di migliorare sé stesso e il proprio lavoro. Il filo conduttore del suo portfolio eclettico sono le ombre e la texture che la direttrice della fotografia del New York Times Magazine, Kathy Ryan, descrive come “schizzi a carboncino”.
La vista di Paolo non è più quella di una volta. All’età di trent’anni gli è stato diagnosticato un glaucoma, una patologia degenerativa dell’occhio, che ora invade la sua visione periferica. Il problema è sotto controllo grazie alle cure, ma il suo impatto psicologico è stato evidente. “Purtroppo la mia vista non è delle migliori e la messa a fuoco automatica, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, è molto importante per me”, rivela. “Anche negli [scatti] in cui non sembra così… in questi riflessi e in questi elementi morbidi, vuoi comunque avere una certa nitidezza. C’è la morbidezza del controluce o del riflesso, ma anche la nitidezza della messa a fuoco: le due cose devono coesistere”.
“Mi sono impegnato molto per conto mio, ma questo forse mi ha spinto ancora di più. Ora forse meno, ma penso sempre all’idea di avere un tempo limitato. Non so fino a quando sarò in grado di fotografare”.
Il collega Gilles Peress, fotografo di Magnum, una volta gli ha detto che la visione fotografica non è solo il risultato dell’intelletto, “ma anche dell’organo, del ‘come’ si vede”. Paolo si identifica con questo concetto. Ha un obiettivo, intellettualmente e fisiologicamente. Escludendo il “rumore” periferico in una composizione, mette in evidenza il necessario: ciò che conta. Tutto ciò che non è rilevante cade nell’ombra.
Tempo limitato e concentrazione
Che si tratti di accettare la sfida di realizzare ritratti di celebrità per il New York Times, di spedizioni del National Geographic, Paolo cerca continuamente di migliorare sé stesso e il proprio lavoro. Il filo conduttore del suo portfolio eclettico sono le ombre e la texture che la direttrice della fotografia del New York Times Magazine, Kathy Ryan, descrive come “schizzi a carboncino”.
La vista di Paolo non è più quella di una volta. All’età di trent’anni gli è stato diagnosticato un glaucoma, una patologia degenerativa dell’occhio, che ora invade la sua visione periferica. Il problema è sotto controllo grazie alle cure, ma il suo impatto psicologico è stato evidente. “Purtroppo la mia vista non è delle migliori e la messa a fuoco automatica, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, è molto importante per me”, rivela. “Anche negli [scatti] in cui non sembra così… in questi riflessi e in questi elementi morbidi, vuoi comunque avere una certa nitidezza. C’è la morbidezza del controluce o del riflesso, ma anche la nitidezza della messa a fuoco: le due cose devono coesistere”.
“Mi sono impegnato molto per conto mio, ma questo forse mi ha spinto ancora di più. Ora forse meno, ma penso sempre all’idea di avere un tempo limitato. Non so fino a quando sarò in grado di fotografare”.
Il collega Gilles Peress, fotografo di Magnum, una volta gli ha detto che la visione fotografica non è solo il risultato dell’intelletto, “ma anche dell’organo, del ‘come’ si vede”. Paolo si identifica con questo concetto. Ha un obiettivo, intellettualmente e fisiologicamente. Escludendo il “rumore” periferico in una composizione, mette in evidenza il necessario: ciò che conta. Tutto ciò che non è rilevante cade nell’ombra.
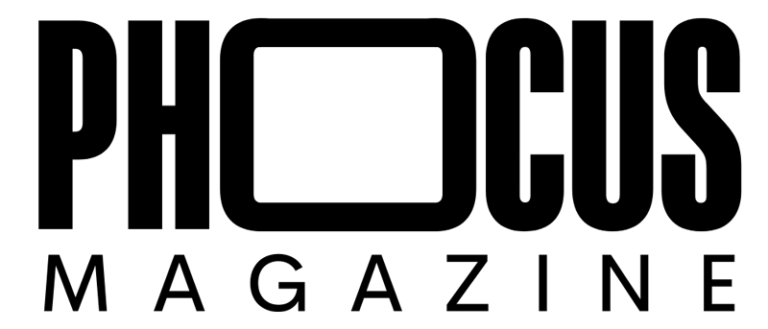










No comment yet, add your voice below!